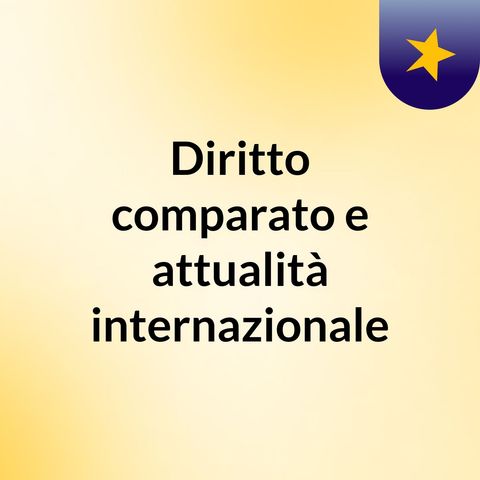
Contactos
Información
I podcast di Radio Radicale con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo
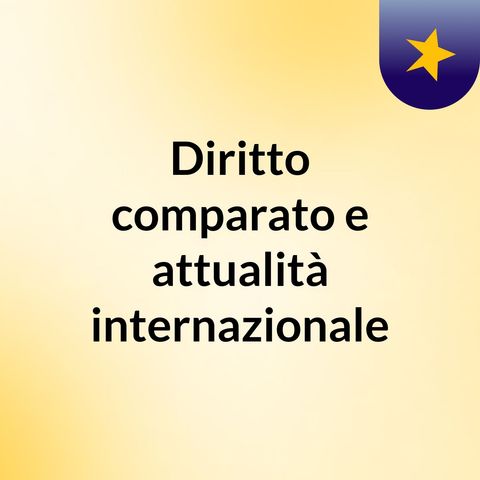
Diritto comparato e attualità internazionale
Diritto comparato e attualità internazionale
Roberta Jannuzzi
28 AGO. 2024 · Il Messico si colloca tra quei paesi in cui, cavalcando un sentimento populista, il potere esecutivo sta cercando, o è riuscito, a controllare il potere giudiziario e la giustizia costituzionale. In attesa dell’insediamento della sua delfina Claudia Sheinbaum, vincitrice alle elezioni presidenziali del 2 giugno con il 64% dei voti, e del nuovo Congresso, il presidente uscente Andrés Manuel López Obrador sta portando avanti un progetto di riforma costituzionale volto a modificare profondamente il potere giudiziario, prevedendo l’elezione diretta dei giudici, con l’azzeramento del sistema esistente. Le divisioni politiche messicane in questi giorni riguardano anche la composizione del nuovo Congresso e il rispetto della norma “contrommagioritaria” che, allo scopo di evitare una sovrarappresentazione, prevede limiti all’assegnazione dei seggi alla maggioranza largamente vincitrice alle elezioni. Ne parla in questo podcast, realizzato da Radio Radicale con le Riviste di Diritto pubblico comparato ed europeo, la professoressa Tania Groppi, ordinario Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università degli Studi di Siena.
28 MAY. 2024 · Ogni cinque anni, i cittadini dell'Unione europea eleggono i membri del Parlamento Europeo, l'unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente. Alle prossime elezioni di giugno 2024, verranno eletti 720 eurodeputati, 15 in più rispetto allo scorso mandato. All’Italia spettano 76 seggi, terzo paese per numero di rappresentanti dopo Germania e Francia. Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale. Il numero di deputati eletti da un partito politico è proporzionale al numero di voti che riceve. Il trattato di Lisbona stabilisce che si deve tener conto dei risultati delle elezioni europee quando il Consiglio europeo, dopo appropriate consultazioni e deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento il candidato alla carica di Presidente della Commissione. Il Parlamento elegge il Presidente a maggioranza dei membri che lo compongono.
Dell’importanza delle elezioni per il Parlamento Europeo ci parla in questo podcast realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo il professor Lorenzo Federico Pace, docente di diritto dell’Unione Europea all’Università del Molise.
12 MAY. 2024 · Il 17 aprile scorso le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza di gennaio, che prova a fare chiarezza dopo decisioni contrastanti. Il tema, ovviamente, ha trovato nuova attualità con l’arrivo al governo di Fratelli d’Italia, partito erede del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale, specie quando i suoi esponenti, considerate le cariche istituzionali ricoperte, sono chiamati a prendere posizione in occasione di celebrazioni ufficiali come la Festa della Liberazione del 25 aprile. Di fronte al saluto cosiddetto “romano” in cerimonie commemorative come quelle di Acca Larentia a Roma o per l’assassinio di Sergio Ramelli a Milano, le Sezioni unite della Corte distinguono le due previsioni penali previste rispettivamente nella Legge Scelba, che delinea un reato di pericolo concreto (le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, che richiedono un’idoneità e una funzionalità alla riorganizzazione del partito) e nella Legge Mancino (diffusione di idee discriminatorie) che richiede solo un pericolo astratto ma anche l’evocazione pur se simbolica di idee di intolleranza e discriminazione razziale. Secondo il professor Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale e pubblico comparato all’Università di Enna e autore di questo podcast realizzato in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo, questa decisione si radica “nella matrice certo antifascista, ma proprio per questo anche liberale e democratica della nostra Costituzione per la quale le idee, finché rimangono tali e non abbiano un concreto contenuto offensivo e una carica istigatrice alla violenza, si combattono con le idee, e non con il carcere”.
Questo è un podcast realizzato da Radio Radicale con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo
Fonti audio
Il saluto fascista ad Acca Larentia, 8 gennaio 2024
Intervento di Ignazio La Russa, Camera dei deputati 13 settembre 2017
Intervista di Michele Lembo, Radio Radicale, a Emanuele Fiano, 19 gennaio 2024
Interviste di Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale: Fabio Rampelli, 10 luglio 2017; Valter Verini, 10 luglio 2017; Vittorio Bruno, 19 gennaio 2024; Angelo Bonelli, 19 gennaio 2024
Intervento di Brando Benifei al Parlamento Europeo, 16 gennaio 2024
Presentazione del libro di Daniele Capezzone, 22 marzo 2024
11 MAY. 2024 · Per fermare l’immigrazione illegale nel Regno Unito, e i rischiosi viaggi su piccole imbarcazioni attraverso la Manica, i governi conservatori di Boris Johnson e Rishi Sunak hanno pensato al deterrente del trasferimento dei richiedenti asilo in un paese terzo, il Rwanda.
Il progetto è stato portato avanti negli ultimi anni con diverse difficoltà dovute all’opposizione politica ma anche alle pronunce giurisprudenziali che, se non hanno riguardato il nocciolo della questione (si può o meno trasferire un richiedente asilo in un altro paese?), hanno comunque richiesto maggiori garanzie rispetto a un paese considerato insicuro, in particolare rispetto alla possibilità di rimpatrio nel paese da cui il richiedente asilo è fuggito.
Per rimediare a questo tipo di censura il governo Sunak ha dunque stipulato un vero e proprio trattato con il Rwanda che prevede maggiori garanzie e che nelle scorse settimane il Parlamento ha infine ratificato.
Ma, mentre si avvicinano le elezioni politiche in cui i conservatori sono dati per sconfitti, non è chiaro se il progetto andrà a buon fine o se ci saranno nuovi ricorsi che sospenderanno la sua attuazione.
Delle criticità di questa vicenda, che coinvolgono i rapporti tra Parlamento e Governo, il ruolo della Camera dei Lord, i poteri delle Corti, le difficili relazioni tra Regno Unito, alcune Corti internazionali e alcuni principi del diritto internazionale, ci parla il professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all’Università di Milano-Bicocca, in questo podcast realizzato con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
Tra le fonti audio che ascolterete, nell’ordine: la notizia della ratifica parlamentare sulla Bbc, il primo ministro Boris Johnson il 14 aprile 2022, la decisione della Court of appeal del 29 giugno 2023, il primo ministro Rishi Sunak il 15 novembre 2023, il ministro degli Interni, James Cleverly il 7 gennaio 2024.
2 MAY. 2024 · In Austria, il prossimo autunno, dopo le Europee di giugno, si terranno le elezioni politiche. I sondaggi da tempo lasciano presupporre la vittoria del partito di estrema destra Fpö, il Partito delle libertà, un tempo associato al nome di Jörg Haider, poi guidato da Heinz-Christian Strache, travolto dallo scandalo di Ibiza, con la pubblicazione di un video che lo mostrava impegnato in una trattativa con una sedicente nipote di un oligarca russo. Oggi il leader è Herbert Kickl e, nonostante diversi casi emersi nei mesi scorsi e l’apertura negli ultimi giorni di una nuova indagine giudiziaria, l’Fpö punta a essere il primo partito, forte di posizioni populiste, filorusse (in un paese che, lo ricordiamo, non fa parte della Nato), euroscettiche (nonostante sia membro dell’Ue e, a differenza dell’Ungheria, anche dell’Eurogruppo) e contrarie ai vaccini. Prendere più voti, tuttavia, potrebbe non bastare. Per governare potrebbe essere necessaria un’alleanza con il Partito popolare austriaco che attualmente è all’esecutivo con i Verdi ed esprime il cancelliere Karl Nehammer, con la prospettiva, in mancanza, anche del ricorso a un governo degli esperti (quello che noi italiani chiameremmo un governo tecnico). Le recenti elezioni locali, che dipingono un paesaggio politico di tutt’altro colore, con il successo nei comuni dei partiti di sinistra, compresa il Partito comunista, completano il quadro di un paese diviso, dove resta centrale la figura del presidente Alexander Van der Bellen, ex esponente verde candidatosi come indipendente, eletto direttamente dai cittadini, che lo hanno confermato nel 2022 per un secondo mandato. Di queste divisioni in un paese tradizionalmente consociativo parla in questo podcast il professor Francesco Palermo, ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac. Questo è un podcast realizzato da Radio Radicale con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
16 ABR. 2024 · Grande sfida sociale del secondo quinquennio di presidenza di Emmanuel Macron, il progetto di legge sul fine vita è arrivato mercoledì 10 aprile 2024 in Consiglio dei ministri e verrà esaminato in prima lettura all'Assemblea nazionale a partire dal 27 maggio.
Il governo preferisce chiamarlo "aiuto a morire", perché parte da una richiesta di un paziente già prossimo alla morte e perché prevede un accurato percorso medico.
Giudicato troppo restrittivo da alcuni, pericoloso da altri, il testo è stato presentato dalla ministra del Lavoro, della salute e delle solidarietà Catherine Vautrin come "un progetto di solidarietà con l'idea di creare uno spazio che non è un nuovo diritto né una libertà, ma un equilibrio tra il rispetto e l'autonomia della persona".
Il Governo sembra preoccupato di non infiammare il dibattito, mentre i sondaggi mostrano che una larga maggioranza di cittadini è favorevole all'eutanasia e molti paesi europei hanno già legiferato.
Del progetto di legge francese, della sua gestazione, dei contenuti e dell’iter previsto, ci parla la professoressa Anna Maria Lecis, costituzionalista, docente associata di Diritto pubblico a Sciences Po Bordeaux, in questo podcast realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
23 FEB. 2024 · Un progetto di legge di iniziativa del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, presentato l'8 marzo scorso, intende costituzionalizzare la libertà di aborto in Francia.
Ricordando la figura dell'avvocata Gisèle Halimi, più di mezzo secolo dopo lo storico processo di Bobigny che aprì la strada alla legge Veil legalizzando l’interruzione volontaria di gravidanza in Francia, il Capo dello Stato ha provato a imprimere una svolta al dibattito parlamentare già in corso.
Ce ne parla in questo podcast Anna Maria Lecis, costituzionalista, professoressa associata di Diritto pubblico a Sciences Po Bordeaux.
Questo podcast è realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
Le fonti audio.
L'8 gennaio 1974, nel programma "Aujourd'hui madame", l'avvocato Gisèle Halimi risponde a un’antiabortista: "Stiamo lottando perché le donne siano libere di scegliere la loro maternità".
Mercoledì 8 marzo 2023 il presidente francese Emmanuel Macron annuncia la sua intenzione di inserire la libertà di aborto nella Costituzione francese, prorpio durante un omaggio all'avvocata e attivista femminista Halimi.
Il 22 gennaio scorso, nel 51esimo anniversario della decisione Roe versus Wade, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rilancia la battaglia sul diritto all'aborto, evidenziando ciò che i democratici ritengono sarà una potente arma politica contro il probabile candidato repubblicano Donald Trump.
E infine Simone Veil il 26 novembre 1974 interviene all'Assemblea nazionale francese.
In un discorso divenuto famoso, l’allora ministra della Sanità difende la legge che depenalizza l'interruzione volontaria di gravidanza.
Cambia la prospettiva del dibattito esponendo questa "convinzione femminile" di fronte a un'"assemblea composta quasi esclusivamente da uomini".
Per questo si arrivò ad accusare Simone Veil, che era stata prigioniera in un campo di concentramento e che aveva avuto la famiglia decimata, di difendere una legge nazista.
23 FEB. 2024 · Il nuovo governo francese del primo ministro Gabriel Attal, sostenuto da una maggioranza relativa e non definita (non c’è stato un voto di fiducia), nella sua composizione sembra proseguire sulla strada di un maggior coinvolgimento della destra nella strategia della seconda presidenza di Emmanuel Macron.
Prima e dopo le prossime elezioni europee, che anche in Francia come in Italia segnano l’agenda politica, e in vista delle presidenziali del 2027, sono numerose le sfide su cui l’esecutivo dovrà misurarsi: dalla protesta in corso di agricoltori e allevatori all’immigrazione, dalle riforme economiche ai temi etici dell’aborto e del fine vita.
Ce ne parla in questo podcast Anna Maria Lecis, costituzionalista, professoressa associata di Diritto pubblico a Sciences Po Bordeaux.
Questo podcast è realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
14 FEB. 2024 · Il 31 marzo prossimo si terranno in Turchia le elezioni municipali.
Mentre sul versante delle opposizioni si attendono ancora i candidati ufficiali, tra molte divisioni dei partiti, l’Alleanza del popolo guadagna tempo e supporto elettorale puntando sul prestigio delle proprie candidature.
Come quella dell’ex ministro dell’Ambiente, in corsa per diventare sindaco di Istanbul, che ha portato avanti il progetto zero waste lanciato dalla Turchia già nel 2017 per combattere il cambiamento climatico.
Il paese, tuttavia, continua a essere percorso da uno scontro istituzionale, con una regressione democratica che sembra interessare soprattutto il potere giudiziario.
Intanto procede il piano del presidente Recep Tayyip Erdogan di consolidare il ruolo della Turchia come potenza regionale.
Ce ne parla in questo podcast Valentina Rita Scotti, che insegna Diritto Pubblico Comparato presso la European Law and Governance School (ELGS) della European Public Law Organization (EPLO) in Grecia, è componente del Centro per gli studi di genere della Koç University di Istanbul, dove ha insegnato Diritto Costituzionale e Diritto e discriminazioni basate sul genere, e autrice del volume 'La Turchia di Erdogan', edito dal Mulino.
Questo podcast è stato realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.
7 FEB. 2024 · Con Francesco Palermo (Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi di Verona e Direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac Research di Bolzano) e Federica Cittadino (Ricercatrice Senior all'Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac Research).
I podcast di Radio Radicale con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo
Información
| Autor | Roberta Jannuzzi |
| Organización | Roberta Jannuzzi |
| Categorías | Comentando la noticia , Noticias diarias , Historia |
| Página web | www.radioradicale.it |
| - |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company
